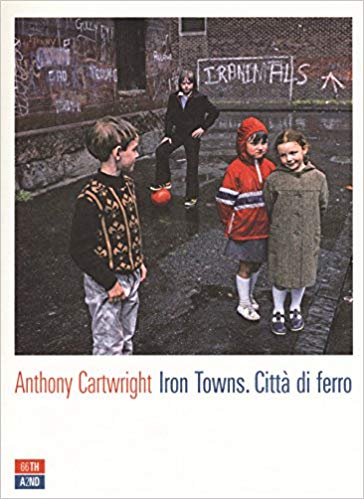
“Attraversiamo i nostri labirinti neri, ombre ammassate. I fuochi sono ormai tutti spenti. Noi siamo il fumo che segna il mattone. Siamo il ruggito di ferro che credevate d’aver messo a tacere. Cantiamo al metallo contorto e lungo tunnel allagati, sopra distese vuote d’acqua e campi di detriti. Cantiamo di giorni migliori”. Sono queste le parole con cui si apre Iron Towns. Città di ferro di Anthony Cartwright (66thand2nd, 2017, uscito in Gran Bretagna nel 2016). Un ritratto cupo e lirico di un distretto industriale in dismissione, di lande dove la nebbia crea un tutt’uno con la polvere e la cenere dei vecchi impianti industriali il cui rombo è ormai solo un lontano ricordo. Un distretto di fantasia ma crudamente reale. I luoghi nominati nel libro in realtà non esistono, ma sono ancorati alla realtà delle Midlands occidentali, non lontano dal confine gallese, dove ai profili delle colline si alternano le vallate ricoperte di cemento, ciminiere e alveari di operai ora perlopiù disoccupati. Anche la squadra di calcio, l’Iron Town Football Club, non esiste, ma la sua storia è quella di tante vere squadre di ogni angolo del mondo, legate in modo indissolubile ai destini altalenanti delle rispettive comunità.
Non è un libro sul calcio, ma un romanzo in cui il calcio occupa un suo spazio non indifferente nella vita dei protagonisti e nella percezione che la comunità ha di se stessa, proprio come nella realtà di miliardi di persone. Del resto, nella letteratura britannica non mancano certo fulgidi esempi di questo approccio sociale al pallone. Ma prima di tutto, è la storia di un gruppo di inseparabili amici di gioventù, separati per forza dalle mareggiate della vita. Liam a 40 anni fa ancora il calciatore, è la bandiera del disastrato Iron Town, e ha già dei discreti conti da fare con il passato, le scelte, speranze, illusioni ed errori. Dee Dee canta divinamente, ma ha smesso e lavora in un pub. Mark era il giocatore più talentuoso del club, ma anni fa sbagliò un rigore troppo importante, mandando in rovina la squadra e se stesso. Ha smesso e ora è praticamente un clochard. Goldie e Sonia stavano insieme da ragazzi, lui era una testa calda, lei è rimasta intrappolata nell’auto guidata da lui tentando una fuga dopo una rapina, e ora lui torna come un minaccioso fantasma. La loro figlia Alina è stata cresciuta da Dee Dee. Le loro vicende si snodano intrecciate a un’abbondanza di momenti introspettivi, flashback, digressioni oniriche, che oltre a raccontare la loro storia dipingono la realtà sociale, in cui la totale decadenza, l’abbandono, la miseria umana assumono addirittura toni epici. Una realtà che sembra destinata inevitabilmente al disastro, a essere divorata dal ferro e dal fuoco che un tempo le diedero vita. In cui l’unica possibilità di salvezza sembra essere provare ad andarsene, già ma alla fine dove, e a fare che?
L’Iron Town Football Club accompagna il vissuto della propria comunità. Gli anni delle gioie, i “giorni migliori”, in cui l’urlo dello stadio faceva il paio con quello degli impianti industriali in piena attività, sono piuttosto lontani, ma ci sono stati, sono vivi in un ricordo piuttosto recente. Poi tutto è arrugginito, addirittura lo stadio ha dei settori chiusi per fatiscenza, i tifosi ci sono ancora, ma sono meno, sono sfiduciati, loro stessi non sono più fieri operai ma scalcinati sottoproletari. La squadra inanella delusioni (quanti esempi ci sarebbero anche qui da noi, nella nostra provincia!), tra la mala gestione societaria e il fatto che tutto quello che sul campo può andare storto, puntualmente succede. L’orizzonte sembra nero uniforme, ma in realtà, anche qui, forse non tutto è ancora scritto, il vento sembra ancora poter girare, anche se non lo sapremo, la decisione in questo caso sta al lettore e al suo tasso di ottimismo e di voglia di riscatto.
Per lunghi tratti Iron Towns è uno spietato ritratto di un angolo di mondo dove il capitalismo ha prima plasmato il territorio a suo piacimento e poi lo ha abbandonato insieme agli esseri che lo abitano. Un ritratto che a tratti sembra compiacersi dell’insistere sul grigiore e la disperazione, e in questo può piacere o meno. La cosa straordinaria è però la capacità di individuare degli elementi che potrebbero cambiare le carte in tavola, in un futuro ambientato oltre la parola “fine” del romanzo. Non c’è rassegnazione totale, non c’è resa al determinismo, non c’è abbandono a un destino che non sembra possibile sfidare. C’è la vita, per quanto ruvida, a cui aggrapparsi con le unghie. C’è la squadra, che potrebbe ancora rinascere. C’è Liam, che da ragazzo aveva addirittura esordito per qualche minuto in Nazionale, e che ha ricoperto tutto il suo corpo di decine di tatuaggi che raffigurano i grandi campioni del calcio nelle loro gesta più celebri, che chiede per la prima volta di farsi tatuare i tifosi, perché senza di loro tutto il resto non ha senso, il calciatore senza la comunità non è nulla, se non un circense destinato all’oblio. C’è Alina, giovane ed estranea al passato operaio della comunità, che vaga cercando nuove radici, nuovi elementi su cui poter costruire le basi di un futuro.
La lezione di Cartwright – una lezione che si scava tra le righe, perché non vi è nessun tono pedagogico o moralistico – è che nonostante tutte le angherie che possa subire, una comunità è in grado, se vuole, di riprendere in mano almeno una parte del proprio destino. Di immaginare nuove identità e nuove strade, laddove le vecchie siano ormai palesemente abbandonate. Questo non sarà certo facile, ci sono di mezzo il dolore e la tragedia, si potrebbe anche non riuscire e soccombere, ma il senso sta proprio nel tentare. Del resto, anche quel passato che ora si rimpiange era comunque fatto di sfruttamento in fabbrica. Non esattamente il giardino dell’Eden. Proprio a poche pagine dalla fine del libro vengono riprese le parole iniziali, con però un’aggiunta fondamentale, che sposta il senso: “Eccoci qui. Arriviamo come le creature ai confini dei vostri sogni, come il grifone e la salamandra. Siamo la cenere che cadrà sulle vostre città, il segno del fumo sui mattoni, le spore che respirerete. Siamo il ruggito di ferro che pensavate d’aver messo a tacere. Cantiamo di giorni migliori. Di giorni migliori di là da venire”. Queste ultime sette parole sono tutto, racchiudono il significato di provare a continuare a vivere in questi luoghi quando ciò sembrerebbe non avere alcun senso: anche quando la coltre di cenere è spessa e fredda, basta che rimanga acceso un tizzone di brace e il fuoco può tornare a divampare.
Matthias Moretti