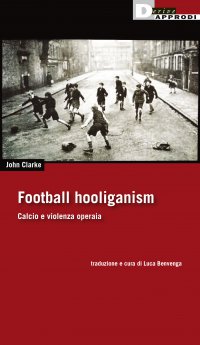
Avete presente quelle serie-tv culto dalle quali poi a distanza di anni viene prodotto il prequel scatenando l’entusiasmo di tutti i fans? Ecco, per chi come il sottoscritto è cresciuto a pane e Valerio Marchi, alla ricerca di un’autocomprensione fondamentale per legittimare le proprie pulsioni più inspiegabili, e proprio per questo più belle, Football Hooliganism di John Clarke (pubblicato da Deriveapprodi con l’introduzione di Andrea Ferreri e traduzione a cura di Luca Benvenga) ha avuto lo stesso effetto, come se si chiudesse un cerchio sul fenomeno del tifo d’oltremanica, con immancabili ripercussioni anche per quanto avveniva nelle curve d’Italia e del resto d’Europa.
Certo, gli studi presi in considerazione saranno anche datati risalendo agli anni ’70, ma nondimeno sono più che validi per analizzare la nascita e lo sviluppo di un fenomeno che nonostante molteplici trasformazioni (talvolta anche radicali) è ancora vivo e vegeto, attraverso l’approccio delle varie scuole sociologiche: quella struttural-funzionalista di impostazione marxista che si raccoglie intorno a Taylor, a cui spetta il merito di essere stato il pioniere in questo tipo di studi; il filone “costruttivista” della scuola di Oxford e del disordine organizzato, della violenza negli stadi come metafora guerresca e dell’ingresso del concetto di moral panic e folks devil che ci sono tanti cari, fino ad arrivare al filone “configurazionista” della scuola di Leicester che si sofferma sulle connessioni tra la formazione individuale dell’hooligan e le strutture sociali collettive.
Sicuramente, il fatto che questi contributi siano stati prodotti prima di diverse svolte che hanno profondamente ridefinito il volto dell’hooliganismo (dall’esplosione del casualismo, alle tragedie dell’Heysel e di Hillsborough su tutte e alla successiva repressione avallata dalla Thatcher, passando per la creazione della Premier League e quindi lo stato ultimo del famoso calcio moderno), ma in ogni caso ci sono alcune intuizioni che si sono inevitabilmente rivelate delle pietre angolari da cui dover necessariamente partire per poter analizzare il fenomeno.
A partire dal nesso tra le squadre di calcio e la classe operaia che, salvo in rarissimi casi, non è mai stata realmente proprietaria di alcuna di esse, ma nondimeno è stata capace di “occupare militarmente” il campo simbolico, identificandosi nei giocatori (anche per via della contiguità tra giocatori e tifosi della working class), che diventavano idealmente alfieri dei valori di quella specifica comunità e di quel territorio, almeno fino a quando non sono comparsi i “germi” della professionalizzazione e della spettacolarizzazione del calcio, quasi un ritorno in auge della borghesia per rimettere le cose al proprio posto. Ed è proprio in questo contesto di imborghesimento dello spettatore medio e di contrasto generazionale in seno alla working class che prende forma l’hooliganismo per come lo conosciamo noi e che raggiunge il proprio apogeo col prepotente ingresso degli skinheads sulle terraces a rivendicare una sorta di resistenza di classe e il proprio “stile maschio violento” e fieramente proletario, soppiantando i mods che invece erano figli della grande illusione della nascita di una società senza classi che a bene vedere voleva dire semplicemente un’accettazione acritica dei valori della borghesia per tutto il corpo sociale.
In questo contesto, è vero che esplode o comunque si automatizza e regolarizza la violenza dentro e fuori gli stadi, ma essa non è altro che uno dei molteplici aspetti di un approccio virile e passionale al football, ma anche più in generale alla vita, tipico della classe operaia che comprende ad esempio anche il sostegno canoro alla squadra a prescindere dal risultato, assistere alla partita in piedi incuranti del meteo e la presenza in ogni posto dove sia impegnata la propria squadra; insomma, tutte quelle cose che anche al giorno d’oggi sono funzionali anche ai padroni del vapore del calcio per rendere più appetibile il prodotto.
Ciò che colpisce è che, nonostante come già accennato i contributi siano datati, potremmo benissimo non accorgercene per via delle problematiche sullo sviluppo del calcio che esso affronta, come la sua modernizzazione, il caro biglietti o la trasformazione degli stadi in salotti realizzati su misura per le fasce di popolazione medio-alte che avrebbero dovuto sostituire i proletari allo stadio, a dimostrazione di come certi fenomeni siano non solo endemici all’interno del calcio, ma che esso costituisce un terreno non solo simbolico, in cui è possibile scorgere abbastanza nitidamente i cambiamenti in seno alla società.
Proprio alla luce di ciò, una critica al calcio moderno, per essere completa, non può essere sganciata da una critica completa all’evoluzione del capitalismo, poiché proprio il calcio è una delle sue industrie più fiorenti e per diventare ciò si è dovuta immolare l’intimità del rapporto tra una squadra e la sua comunità di riferimento sull’altare della spettacolarizzazione e dello show-business, cosa che pur con tutti gli inevitabili distinguo del caso tra il panorama anglosassone e quello italiano, purtroppo abbiamo imparato a conoscere e a subire sulla nostra pelle. Pur non volendo scivolare nell’apologia aprioristica degli hooligans o degli ultras, è innegabile che nonostante i tanti passi falsi commessi dai protagonisti in questione che in tanti non esitano minimamente a spiattellare, il fenomeno del tifo viscerale allo stadio e dei suoi interpreti è riuscito a sopravvivere a così tanti scossoni che potrebbe benissimo essere preso d’esempio per la capacità di sopravvivenza e di sapersi adattare alle intemperie e alla criminalizzazione tout-court.
Certo, i tempi sono cambiati: nell’epoca della finanziarizzazione del calcio, delle plusvalenze e delle quotazioni sulle borse asiatiche, il tifoso accanito, quello che segue la squadra ovunque e che per essa è pronto a tutto, ma davvero a tutto, potrebbe quasi sembrare obsoleto, un reperto archeologico di un passato da cancellare al più presto, e poi le gradinate non sono più una roccaforte del proletariato (anzi l’interclassismo è diventato una bandiera) e se qualcuno si aspettasse che la rivoluzione partirà dalle curve, con ogni probabilità resterà deluso, ma questo aspetto dipende dall’equivoco di voler adattare la realtà alle proprie fantasie e vedere focolari di rivoluzione anche dove non ce ne sono. Tuttavia è allo stesso tempo innegabile che nonostante le molteplici contraddizioni, nel bene o nel male, dai Balcani al Maghreb, dalla Grecia al Brasile, passando appunto per l’Italia e l’Inghilterra, le curve sono ancora una delle poche oasi dove è possibile socializzare dal vivo e una palestra in cui praticare quel conflitto che altrove invece si ipotizza e idealizza.
Giuseppe Ranieri
