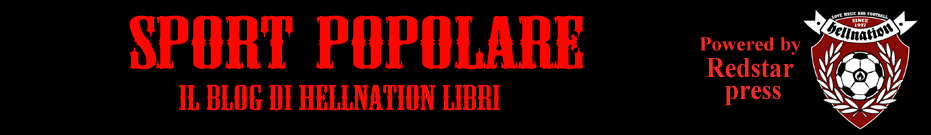Nel corso della nostra attività ci è capitato più volte di seguire e documentare quanto i gruppi ultras siano stati importanti, se non a tratti decisivi, per la crescita e lo sviluppo delle proteste nei paesi del Maghreb che hanno assunto il nome univoco di “Primavere arabe”, nonostante spesso queste avessero caratteri mutevoli di nazione in nazione. Forse una delle poche costanti, principalmente per quel che riguarda Egitto e Tunisia, era proprio rappresentato da quell’elemento di rottura, prevalentemente giovanile e oltranzista, incarnato dai frequentatori delle curve che in tutto il contesto nordafricano rappresentano uno dei pochi spazi di dissenso e autorganizzazione consentiti. Anche il Marocco non è stato del tutto esente né dai sommovimenti sociopolitici né dalla presenza in essi dei supporters più esagitati.
A distanza di diversi anni adesso è il turno degli ultras algerini scendere in piazza e farsi autorevoli rappresentanti di un malcontento che è esondato nelle ultime settimane, per via della candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika al quinto mandato consecutivo, ma sarebbe errato considerare ciò un fulmine a ciel sereno. Anzi, sostanzialmente si potrebbe affermare che l’Algeria (il decimo paese al mondo per estensione) la sua “primavera” in un modo o nell’altro, l’ha vissuta oltre trent’anni fa nel 1988 e da allora ha vissuto un periodo di calma apparente, ma andiamo con ordine.
Lo stato nordafricano ottenne l’indipendenza nel 1962 al termine di un cruento conflitto, forse uno dei più brutali e conflittuali processi di decolonizzazione, contro la “madrepatria” francese durato ben sette anni e costato oltre un milione di morti (in maggioranza civili) in cui, come ogni tanto attualmente ricordano in maniera del tutto strumentale gli autoproclamati sovranisti nostrani, Parigi ha dimostrato quanto le potenze liberaldemocratiche potessero essere crudeli e senza scrupoli, proprio come quelle “totalitarie” che hanno combattuto, e quanto potesse essere declinabile e prestarsi a giustificare l’ingiustificabile il fantomatico “fardello dell’uomo bianco”. Nel 1988 le molteplici pressioni dal basso (rivendicazioni sindacali, le lotte per le rivendicazioni sociali della minoranza amazigh e le proteste del popolo che reclamava casa e reddito) misero fine al sistema a partito unico e diedero il via a un’effimera stagione di pluralismo politico e culturale. Effimera, perché un colpo di stato annullò i risultati delle elezioni che avevano visto vincere al primo turno il Fronte Islamico di Salvezza, decretando così l’inizio di una guerra civile durata quasi 15 anni.
Nel 1998, a margine dei primi accordi di pace, salì al potere Bouteflika (che aveva partecipato in maniera del tutto limpida alla guerra di liberazione e successivamente era diventato ministro) come garante della stabilità imposto sia all’esercito che alla guerriglia islamica, col tacito accordo di un’amnistia de facto per entrambe le fazioni e di estromettere le multinazionali dallo sfruttamento dei vasti giacimenti di petrolio algerini, riuscendo così a redistribuire privilegi in seno alla popolazione creandosi una vasta clientela che gli diede quella rendita politica di cui per certi versi gode ancora oggi.
Contrariamente alle aspettative, il presidente, chiamato dai suoi detrattori “il marocchino” essendo nato a Oujda, si dimostrò un politico abile, fu in grado di giocarsi al massimo le sue chances e, sfruttando il poderoso aumento del prezzo del greggio riuscì a governare silenziando le opposizioni.
Ma nel 2013 venne colpito da un ictus e da allora, nonostante le cure nelle migliori cliniche europee, la sua salute degenerò fino a diventare quasi incapace di intendere e volere.
Nonostante ciò, nessuno del suo clan appare oggi in grado di sostituirlo alla guida del paese, e da qui quella sua candidatura dal forte retrogusto “fideistico”, cosa che non è passata inosservata a diverse fette della popolazione colpite anche dalla caduta dei prezzi del petrolio e dal conseguente abbassamento del tenore di vita dovuti alla forte crisi economica che attraversa l’Algeria.
Questa volta, a differenza degli schemi tradizionali, la rivolta non è circoscritta alla sola Algeri, ma riguarda numerosi centri urbani (da Oran a Costantina fino alla Cabilia) oltre che i social network e… le curve.
Infatti, in maniera del tutto spontanea, senza coordinazione in diversi stadi algerini si è cominciato a intonare cori contro il “mandato di troppo”.
Se proprio il calcio e gli ultras si trovano al centro di questa protesta, come riportano diverse foto degli scontri avvenuti il primo marzo, da un lato lo si deve sicuramente alla disorganizzazione e all’apatia di un’opposizione incapace di contrastare un candidato “assente” e dall’altro all’importanza che ha il calcio per il popolo algerino e in particolare per i giovani, vero motore della protesta in quanto principali vittime della crisi economica.
Basterebbe farsi un giro nelle curve degli stadi algerini, vedere i simboli delle squadre e dei gruppi alla testa dei cortei di protesta, ascoltare gli slogan e leggere i messaggi sugli striscioni per rendersi conto di trovarci, come spesso accade a ogni latitudine, in una delle ultime roccaforti antigovernative, capace di dare amplificazione agli appelli anonimi lanciati sui social network e di dare una continuità al protagonismo popolare-curvaiolo già sperimentato durante l’amichevole della nazionale algerina contro l’Arabia Saudita ad Ain M'lila nel dicembre 2017, quando i supporters di casa tramite cori e striscioni lanciarono pesanti ingiurie agli ospiti imputandogli l’accettazione acritica della scelta di Trump di istituire l’ambasciata statunitense in Israele a Gerusalemme. A seguito di ciò la diplomazia algerina fu costretta a chiedere pubblicamente scusa alla monarchia saudita. Infatti a differenza delle generazioni più anziane di rivoltosi, i giovani dei quartieri popolari nelle loro manifestazioni hanno adottato e riadattato cori da stadio che ormai non sono più patrimonio della tifoseria che li ha partoriti, ma condivisi da tutti i gruppi che per l’occasione hanno sotterrato l’ascia di guerra per unirsi contro il nemico comune. Come ad esempio “La Casa De l'Mouradia”, (la “Mouradia” indicherebbe la residenza governativa e il riferimento è chiaramente alla serie Tv “La casa di Carta”) un testo che parla di disagio, frustrazione e di volontà di ricorrere all’esilio o peggio ancora “all’emigrazione del mare” per colpa dei politici. Questa canzone è stata “inventata” dagli Ouled El Badja, il principale gruppo ultras dell’USM Algeri e probabilmente di tutto il paese, e ora intonata anche da tifoserie storicamente rivali e recita testualmente: “ Nel primo [mandato], abbiamo avuto il decennio nero [e il bisogno di riconciliazione nazionale] nel secondo, è diventato più chiaro, è Casa del Mouradia; il terzo, il paese ha perso peso a causa di interessi personali; il quarto, il burattino è morto, ma la relazione continua; il quinto proseguirà ciò, è già scritto”; stesso destino per il coro “Fbladi Dalmouni” (“Nel mio paese sono oppresso”)
Dal canto loro, le autorità sportive hanno colto questo legame che si sta sviluppando e con la Federcalcio algerina (FAF) in testa hanno disposto la sospensione del campionato nell’ultimo weekend di febbraio, per motivi di ordine pubblico, mentre lo scorso fine settimana le partite si sono disputate (compreso il match clou tra il Paradou e l’USM Algeri che sembrava fortemente a rischio e infatti è stato rinviato di 24 ore), ma sembra che anche il prossimo turno subirà delle menomazioni nonostante il presidente della Lega, Abdelkrim Medouar, non mostri preoccupazione e assicura che a breve il torneo riprenderà il suo normale svolgimento, anche se l’impressione generale è che queste dichiarazioni siano eccessivamente ottimiste, visto che il prosieguo del campionato algerino appare tuttora abbastanza incerto e di conseguenza le entrate che esso genera (non potendo ritrasmettere le partite a porte chiuse per il diktat della lega calcistica algerina), ma pone interrogativi anche sui tre club ancora impegnati nelle competizioni internazionali (JS Saoura, CS Costantinois e Nas Athletique de Husssein Dey), soprattutto perché la sensazione che predomina è quella di un’incertezza che travalica il campionato e la sua continuazione, ma riguarda la diffusione della protesta che potrebbe pregiudicare altri eventi sportivi. L’unico dato incontrovertibile in questo momento è che il calcio è sempre nella veste di catalizzatore del malcontento e gli ultras in quelle di scintille pronte a infiammare le praterie del dissenso.
Giuseppe Ranieri