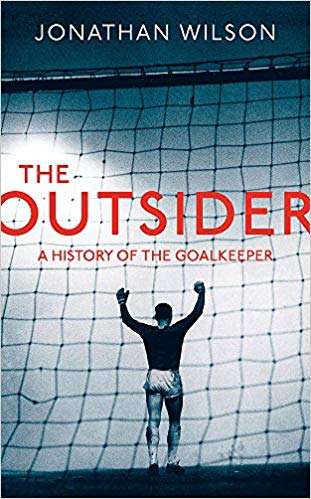
Non esiste alcuna figura in campo sportivo, e in particolare in quello calcistico, che riesca a esaltare quel romanticismo, quel misticismo di cui è carica la figura del portiere. Storie di uomini veri, eccentrici, fissatisi, nel bene o nel male, nell’immaginario popolare, odiati, amati, esorcizzati.
Wilson, giornalista, scrittore sportivo, direttore del magazine trimestrale The Blizzard, con il suo Il portiere. Vite di numeri uno (titolo originale Outsider, Isbn edizioni, 2013), ci regala un libro che ripercorre, quasi come in un romanzo epico, le vicende dei più grandi interpreti di questo ruolo dagli albori del calcio fino ai nostri giorni. E lo fa intrecciando specificità tecniche e storie personali e sportive, al netto dell’umanità intrinsecamente solitaria dell’uomo con l’Uno sulle spalle.
Non è, o non è solo, un libro per addetti ai lavori, ma un libro che rende in qualche modo giustizia a una specificità sportiva che si è continuamente evoluta nei primi centocinquanta anni del calcio secondo un percorso non sempre lineare, ma tortuoso e pieno di contraddizioni.
Basti pensare che ai primordi del calcio il ruolo del portiere non solo non era contemplato, ma poteva essere intuito come quello di un «portatore di carestia», come ci suggerisce l’autore. Nei primi giochi di palla, antichi progenitori del calcio, il goal sanciva l’ipotetica benedizione per un raccolto favorevole o per accaparrarsi simpatie divine. Il portiere rappresentava allora come oggi l’antagonista: «La stranezza del portiere è una riluttanza ad accettarne l’unicità. Ecco che il sospetto con cui viene guardato diviene naturale».
Nei primi esperimenti calcistici a squadre, quello del portiere era un ruolo punitivo, un ruolo di scarto. Tanto che nei college inglesi, dove nacque il gioco, esso era relegato alle matricole e proprio la tenacia o la vigliaccheria che esse dimostravano, schierate come ultimi baluardi, potevano segnare l’inizio o la fine della loro carriera calcistica.
Gli inventori del calcio – gli inglesi appunto – non avevano pensato a una specificità della funzione del portiere ed erano istintivamente ostili a questa figura isolata e decontestualizzata. Eppure furono gli stessi inglesi a sancire la nascita del moderno gioco in porta. L’emergere del ruolo come oggi lo conosciamo si deve a una lenta cristallizzazione di posizioni e tecniche, complicata tuttavia da una costante riluttanza nel concedere uno status particolare all’ultimo giocatore.
Nel primo regolamento del gioco, formalizzato dall’FA già a fine Ottocento, non era prevista alcuna specifica tutela del portiere durante il match e così – racconta Wilson – in quegli anni le cariche sull’estremo difensore erano una tattica di gioco diffusa e riconosciuta: teste rotte, mascelle slogate e occhi neri come in un incontro di boxe erano la normalità.
Si tratta degli anni in cui emergevano figure come quelle di Foulke e Roose, antesignani dei moderni Cech e Neuer. Il primo incarnava tendenzialmente lo stereotipo del portiere pazzoide, spocchioso, attaccabrighe, smargiasso. Aiutato senza dubbio da un fisico notevole (1,94 m per 129 kg), ma inaspettatamente dotato di un’agilità felina.
Roose, più cauto, fu tra i primi a mostrare che il portiere non era solo quello che dava e prendeva botte, ma un giocatore funzionale al gioco di squadra. Partecipava, rilanciava l’azione: una vera rivoluzione (siamo nel 1887!).
Altro portiere unico e precursore dei tempi fu sicuramente Elisha Scott, estremo del Liverpool che andò oltre i suoi predecessori, curando oltremodo l’estetica e il temperamento da tenere in campo.
Ma è sicuramente Roose ad aver infranto il muro d’ostilità nei confronti del portiere, allacciando un formidabile connubio tra professionalità, atletismo e protagonismo (usufruendo delle regole d’allora che permettevano al portiere di prendere la palla con le mani fino al centrocampo). Di fatto, Roose diede vita a una legge ad personam: l’FA, per preservare la spettacolarità del gioco, pensò infatti di relegare il portiere nella sua area a partire dal campionato del 1911-12.
Nel 1914 Roose, il portiere “da tenere a bada”, fu chiamato alle armi e perse la vita presumibilmente in Italia, nei pressi di Gallipoli.
Una delle caratteristiche più affascinanti del ruolo del portiere è senz’altro quella delle diverse declinazioni che esso assunse – e assume – nei vari paesi del mondo.
Se nel vecchio continente i bambini sognavano di essere i nuovi Mazzola, Pelè, Puskas o Best, tra dribbling e fantasia, l’Urss si contraddistinse anche in questo. Lì ogni bambino che vedeva una palla rotolare sognava di emulare l’immenso e unico “Ragno Nero”, Lev Yasìn.
Fu senza dubbio il più grande portiere della storia del calcio, ma anche un esempio di patriottismo, fermo sostenitore del processo di trasformazione della società in atto nell’Unione Sovietica. Per certi versi incarnò quel minimalismo sovietico e quell’attaccamento ai valori del sacrificio, del collettivo e del popolo. Ad onor del vero, la sua figura era nota già antecedentemente alla rivoluzione del ’17, comunque assurse a icona del comunismo, partecipe e sempre in linea con l’avanzare della costruzione del socialismo nel suo Paese.
Racconta la moglie: «A fine stagione riconsegnavamo tutto il materiale alla Dinamo e Lev rattoppava i guanti per riconsegnarli allo Stato nelle migliori condizioni»: questo fu il compagno Yasìn.
Il mito del ruolo del portiere in Russia ha ragioni molto profonde e radicate, avallate anche da una serie di romanzi imperniati proprio sulla figura dell’estremo difensore.
Per esempio Vratar Respubbliki, del 1936, o Zavist di Jurj Olesa, in cui si narrano le vicende di Makarov, portiere pronto al sacrificio estremo pur di difendere la propria squadra, il messaggio rivolto al contributo che ciascuno può dare alla costruzione del tutto.
O come non citare, ancora nella Russia sovietica, la vicenda del formidabile portiere Trusevic, che durante l’occupazione nazista decise di abbandonare i guanti per imbracciare le armi con la resistenza ucraina. Orgogliosamente non decise di collaborare con l’occupante – come fecero molti sportivi che videro nel nazismo un occasione – e lo combatté fino alla fine. Onore a lui e alla sua memoria.
Tornando a Yasìn, la sua incredibile ascesa sportiva potrebbe dar adito alla visione di una vita sportiva scevra di sconfitte e drammi personali. Come ogni suo collega di reparto, al contrario, anche il più grande di tutti fu distrutto dalla critiche e messo sulla graticola, nonostante la sua impressionante media di partite giocate senza subire reti, talento che, peraltro, gli fruttò la più alta onorificenza del suo Paese: il riconoscimento dell’ordine di Lenin.
Nella coppa del mondo del 1962 fu accusato come responsabile dell’eliminazione della nazionale sovietica e ne fu talmente scosso che si ritirò. Per un breve periodo, per fortuna.
Tornò più forte di prima e raggiunse un traguardo che nessun portiere ha eguagliato: l’assegnazione del Pallone d’oro. Nel 1966 un portiere era il più forte giocatore di calcio del mondo (quell’anno parò un rigore a Mazzola!).
Yasìn fu imbattuto nel 48% degli incontri disputati e questo, per chi ha familiarità con questo tipo di statistiche, dice davvero molto.
Un altro grandissimo portiere sovietico che merita di essere citato, non solo per i suoi meriti sportivi, è Dasaev: egli smentì categoricamente la diceria per cui i professionisti venivano vessati e intimoriti dai vertici sovietici e andò oltre, dichiarando: «lo stile di vita e le possibilità di un professionista erano maggiori di un cittadino medio, avevamo accessibilità a tutto e tutto costava poco, le case, le automobili, viaggiavamo spesso e non ci siamo mai sentiti costretti, eravamo parte integrante della società comunista».
Nel 1990, però, fu il primo calciatore ex sovietico ad approfittare della legge che gli consentì di accasarsi a Siviglia.
Qui non esplose mai come calciatore, fu accantonato e visse un periodo in povertà, proprio lui, maggior talento in patria: le insegne luminose attirano gli allocchi.
«La Russia ti abbraccia con naturale dispotismo di una madre terra, mentre loro provano per lei la tormentata tenerezza del supplicante».
Un altro caso emblematico ci porta in Brasile e ci parla delle vicende di Moacir Barbosa: la storia più triste, deprecabile e infame tra le storie di calcio. Macchiata di quel razzismo vigliacco e quella superstizione becera che a volte cela l’incapacità di analizzare lucidamente episodi e sconfitte. Barbosa fu l’icona dei pregiudizi esistenti nel mondo del calcio, che si propagano fino ai nostri giorni.
Moacir Barbosa era nero. Moacir Barbosa era il portiere titolare della più grande sconfitta calcistica che il Brasile abbia mai conosciuto. Il Brasile Paese ospitante della Coppa del mondo del 1950, quel Brasile contagiato da un effimero ottimismo e speranzoso di un rinnovamento economico e politico. Il Brasile che si apprestava a inaugurare il più grande degli stadi di calcio che il mondo abbia mai conosciuto: il Maracanà.
In quella finale maledetta, fino a 11 minuti dalla fine tutto era nella norma, Brasile in vantaggio e caroselli pronti a esplodere nelle strade. Poi il buio e due lampi: Schiaffino e Ghiggia decretarono l’incredibile rimonta. «La nostra Hiroshima», sentenziò Nelson Rodrigues.
Quel goal di Ghiggia assegnò il trofeo all’Uruguay e segnò un altra fine, quella di Barbosa.
La gente sentiva l’esigenza di trasformare un fatto normale in un evento straordinario, così per la “Waterloo dei tropici” serviva un capro espiatorio. Nonostante un eccellente campionato che gli valse comunque il premio come miglior portiere della Coppa, Barbosa doveva essere crocifisso, strano destino riservato ai portieri.
«La conseguenza peggiore di quella giornata fu la preclusione a prescindere per mezzo secolo di tutti i portieri neri». Si affermò l’idea che non si potesse avere portieri neri in squadra e Mario Zagallo nel 1993, durante delle riprese della BBC, vietò a Barbosa persino l’ingresso negli alloggi e nel campo di allenamento, «perché portava sfortuna».
In una intervista del 1970 Barbosa raccontò quello che definì il momento più triste della sua vita: entrando in un negozio una mamma, riconoscendolo, si rivolse al figlio dicendo: «vedi quello è l’uomo che ha fatto piangere tutto il Brasile».
«In Brasile ho ricevuto la più grande condanna nei primi trent’anni di vita, ma la prigione l’ho scontata nei successivi cinquanta», affermò il portiere, morto nel 2000 in completa povertà. L’anno successivo Dida esordì in nazionale, il primo portiere nero a cinquanta anni di distanza da Barbosa.
Altro paese, altre storie. Voliamo in Spagna, il Paese d’origine del portiere più forte degli anni Trenta, Ricardo Zamora, conosciuto persino da Stalin, tanto forte e tanto famoso che durante la Guerra civile, tanto gli antifascisti quanto i golpisti cercarono di affibbiargli imprese e l’appoggio incondizionato all’una o all’altra causa. Wilson un’idea se l’è fatta – e noi con lui – basti pensare che Ricardo fu tributato dell’ordine della Repubblica dal suo omonimo, il presidente Nieto Zamora.
Fu portiere del Real Madrid, squadra che divenne esplicitamente filo-franchista solo quando ne prese la guida Bernabeu, ma le sue idee politiche a onor del vero risultano tutt’ora confuse e oggetto di discussione. Lo stesso Mussolini si vide sollevato quando, nei quarti di finale del ’34 (nella partita di ripetizione), tra i pali non vide quel “bolscevico” di Zamora, infortunato.
Come estremo difensore, comunque Zamora segnò un’epoca e un modo di essere divo e protagonista: «negli anni Trenta Zamora piaceva più della Garbo».
Dopo Zamora ci fu Ramallet, “il gatto con le ali”, poi fu il turno della scuola basca. Probabilmente un qualche ruolo in questo successo generazionale lo ebbe la tradizione della pelota, popolare gioco basco in cui destrezza ed eccezionali riflessi erano condizioni basilari.
Iribar, basco, portiere della selezione non ufficiale di Euskal Herria, e per 49 volte della nazionale spagnola, fu un grande interprete del ruolo, nonché uomo di spessore sempre contro, sempre critico verso la modernità del calcio e la dittatura mediatica cui il gioco è afflitto. Fu da sempre solidale e sostenitore della causa basca e dei prigionieri politici baschi.
Fui lui, insieme a Kortabarria, in un derby col Real Sociedad del 1975 a portare l’Ikurrina in campo segretamente e ad esibirla nonostante il divieto franchista ancora vigente, gesto che contribuì in maniera efficace alla legalizzazione della bandiera con il portato politico e di lotta che essa rappresenta e che noi tutti difendiamo. Fu questo, e non una parata, «il ricordo più bello legato al mondo del calcio» per il portiere.
Un altro ricordo è legato a un match con il Barcellona, giocato in concomitanza con la festa dell’orgoglio regionale, che era stata soppressa da Franco, in un tripudio di Ikurrina e bandiere catalane: «Fu una manifestazione di gioia collettiva, la dittatura era finita, c’era una sincera voglia di partecipazione al rinnovamento democratico in corso, gli stadi, cosi come le strade le scuole eccetera erano affamate di libertà».
Dopo di lui vennero Andoni Zubizarreta, cresciuto ad Aretxabaleta, e poi uno dei più grandi: Luis Arconada di San Sebastian, la cui presa ferrea gli valse il soprannome de “El Pulpo”.
Ma, come succede spesso, nonostante una carriera folgorante Arconada è tristemente famoso per il clamoroso errore commesso nella finale dell’Europeo del 1984 su tiro di Michel Platini.
Un errore e la tua carriera è segnata. Non importano a volte i titoli vinti, le parate straordinarie, i riflessi felini, i rigori intercettati: la vita di un portiere si conta in attimi.
La stessa sorte subì il già citato Zubizarreta che, nel Mondiale del 1998, con un errore grossolano spianò il passaggio del turno alla Nigeria.
La reiterazione dell’immagine dell’errore, della “papera”, come aveva intuito Iribar, sostituisce nell’immaginario collettivo la fantasia ed è cosi che l’errore diventa emblema.
Non più le parate leggendarie a stagliarsi nella storia indelebile di ogni generazione come quella compiuta da Zamora nell’“ultimo clasico” prima della Guerra civile.
La foto, l’immagine di un uomo, berretto in testa, proteso, bello e in tensione, che in un nuvolone di polvere strozza l’urlo della vittoria nella gola di migliaia di tifosi del Barcellona e regala un trionfo al suo Real, rappresentò un messaggio chiaro: da qui non si passa.
Wilson sembra suggerire che un po’ di quel carattere donquisciottesco sia ben radicato tra i portieri spagnoli e nel modo di percepirli: «Lui personifica gli ideali che avrebbero dovuto rendere grande la Spagna, roccaforte contro il nemico ma anche giustificazione del proprio fallimento». Beh, senza dubbio anche Don Quisciotte doveva sentirsi un po’ Outsider.
Avremmo potuto lasciarci con le parole di Umberto Saba o di Albert Camus, ma è forse Eduardo Galeano a centrare poeticamente il destino del portiere: «Porta il numero uno sulla schiena. Il primo ad essere pagato? No il primo a pagare. È sempre colpa del portiere e se cosi non fosse è sempre con lui che bisogna prendersela. Quando un qualsiasi giocatore commette un fallo da rigore è immancabilmente lui a subirne le conseguenze. Lo lasciano lì, nell’immensità della porta vuota, solo ad affrontare il suo boia».
Daniele Poma
