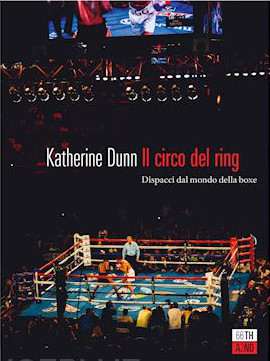
Cosa sarebbe oggi di Katherine Dunn se nel 1980, per qualche motivo, non avesse acconsentito alla richiesta del marito che mentre usciva di casa le chiese il favore di seguire un incontro di pugilato in tv per poi raccontarglielo al suo ritorno, non è dato saperlo. È un fatto però, per sua stessa ammissione, che l’avventura dell’autrice come cronista della noble art inizia esattamente in quel momento, come raccontato non senza ironia nella prefazione del suo libro Il circo del ring. Dispacci dal mondo della boxe, pubblicato nella sua versione italiana da 66th&2nd e tradotto da Leonardo Taiuti.
Sezionando l’opera in questione, i seguaci della matematica troveranno spunti interessanti. Ci sono ventidue articoli, un’introduzione e un epilogo. Duecentosettantadue pagine. Nel campo delle suggestioni quindi questo è un libro palindromo, con echi cabalistici. Più semplicemente, però, sono trent’anni di cronache appassionate del ring in cui vagare, scritte da una delle voci più autorevoli del pugilato americano. Un condensato di grandi campioni e piccole storie pubblicate su giornali e riviste come «The Ring», «Sports Illustrated», «Vogue», «New York Times», «Esquire» «Playboy» e soprattutto «Willamette Week», che ritraggono l’arte marziale più antica del mondo, nuda e cruda, raw & uncut. Autentica e senza fronzoli.
Intanto quando si sfoglia il libro succede qualcosa. Una colonna sonora monta a ogni pagina. Anche se è carta suona come un vinile. Qualcosa gracchia e tutto comincia. Si sentono corde che toccano ritmicamente terra, colpi al sacco, acuti sui “guanti da passata”, sirene che governano le riprese. Poi, via via, sonorità sempre più complesse: evoluzioni di petto e diaframma dei ring announcer, voci roche di allenatori che cercano di sovrastare il sottofondo. Boati del pubblico. Sibili scattanti dell’arbitro che grida: «Booooxe». C’è la musica dei pugni. Lo spartito delle palestre. Battere e levare. Destro-sinistro. Armonie del ring.
A dirla tutta però Katherine Dunn non sceglie il quadrato in quel giorno di gloria del 1980, quando diventa cronista per una casualità della vita. Ci si imbatte molto prima, quando è ancora una bambina. In un periodo in cui il ring appartiene alla collettività, entra spesso nelle case, ed è un fenomeno di massa: «Quando ero piccola, e stiamo parlando della metà del Ventesimo secolo, la boxe era il sogno delle tute blu di tutta l’America. I ragazzi la imparavano a scuola, in chiesa o nei centri ricreativi». Si affeziona in quegli anni, quando una passione così è tabù e suona come una sfida: «La mia famiglia era piuttosto ordinaria, nella misura in cui gli uomini amavano la boxe e mia madre disapprovava. La riteneva barbara e volgare. Il che fu più che sufficiente a farmici appassionare».
Uno degli spunti più apprezzabili del testo è la rievocazione del vecchio pattern romantico del ring come rifugio. Una scappatoia dalle nefandezze quotidiane, dalle scorrettezze della vita. «Non sono mai stata una che guarda con rimpianto ai vecchi tempi. Ricordo che quell’America, quella del secondo dopoguerra, era un luogo turbolento. Razzismo e sessismo erano onnipresenti, istituzionali. Picchiare la moglie era tollerato. I ceffoni e le cinghiate ai bambini, a scuola o fra le mura domestiche, facevano parte del gioco. Le gang di strada erano diffuse, e le risse infuriavano nelle vie, nei parchi gioco, nelle taverne e sui luoghi di lavoro. In quegli anni i pugili mi sembravano gente particolarmente civile. Non gridavano, non fischiavano. Non usavano coltelli, catene di bicicletta o pezzi di tubature, e si battevano solo al suono della campana. E quando la udivano una seconda volta, si fermavano. Straordinario». Poche semplici regole, ma inderogabili.
Insomma l’autrice non sente il bisogno di addolcire il pugilato: è uno sport violento, duro, è inutile negarlo, ma paradossalmente la vita – quella dei soprusi, della sopraffazione, ma anche banalmente delle bollette, dei mutui e dello sfruttamento – lo è di più. E in ogni dispaccio – come vengono intelligentemente chiamati i suoi scritti, sospesi fra cronaca, reportage e racconto – si respira costante quest’idea suggestiva del ring come “camera bianca” dell’esistenza, luogo neutro fuori dallo spazio e dal tempo, dove non conta tanto il pedigree o il punto di partenza, ma solo quanto si è disposti a sacrificare. E a perdere.
Da più parti è stato evocato il parallelo con Sulla boxe di Joyce Carol Oates (pubblicato sempre da 66th&2nd) grande classico della nobile arte e della letteratura sportiva in generale. Sicuramente le similitudini non mancano, soprattutto a livello stilistico. E in un certo senso i due libri percorrono sentieri narrativi speculari e condividono anche un certo sguardo sulle cose umane. Ma, a essere sinceri, mentre Oates descrive con maestria i giganti dello sport e l’epica del pugilato – gli allori, i campioni, il riscatto e i drammi – Dunn incanta il lettore e dà il meglio di sé quando indugia sul pugilato degli amatori, dei guantoni maleodoranti, dei tassisti-allenatori, delle donne discriminate che conquistano il ring mettendo ko i pregiudizi.
Questi articoli suonano come inno agli ingranaggi imperfetti di questo sport – appunto gli ultimi, gli sconfitti – che incarnano la bandiera più autentica della sweet science, il suo miglior biglietto da visita. Così come non mancano i momenti di tenerezza, molto più comuni di quanto si immagini: «Ho visto svariati pugili presentarsi in palestra con i bambini. Malgrado l’estenuante etica del lavoro e gli atteggiamenti feroci insiti in questo sport, non è insolito trovare un bimbetto dell’asilo che disegna spensierato in un angolo, o che salta una corda appositamente accorciata. Non mi sorprende più sedermi vicino a un borsone da palestra aperto e vederci dentro un neonato che dorme della grossa in un nido di guantoni di pelle macchiati di sudore». Il pugilato è sweet, dolce come uno zucchero.
Difficile ma travolgente anche il confronto con un “campioncino” che mette a nudo i pregiudizi di Dunn: «Mentre ero appollaiata sulla panca di un’altra palestra di boxe, mi ritrovai a osservare un minuto ma amabilissimo ragazzino di nove anni che si allenava sul ring. Alla fine della seduta, prima di andarsene, quel bambino è venuto da me per farmi vedere il cagnolino che teneva sotto il giubbotto. Prevedibile come tutti gli adulti, io gli chiesi cosa volesse fare da grande. Mi aspettavo che sognasse di diventare campione del mondo, o una cosa così. Invece mi rispose: “Mi raduno un gruppo di zoccole e faccio il pappone”. Pronunciò quelle parole con l’impassibilità di una lapide. Non capivo se dicesse sul serio o se volesse prendersi gioco di un’altezzosa piccolo borghese come me, ma in ogni caso mi colpì. In genere le palestre di boxe sono posti tranquilli, ma non bisognerebbe mai perdere di vista quello che c’è fuori». Lo sport in fondo è sempre lo specchio della società.
Altri due dispacci meritano una piccola menzione: Fasciature, dove si descrive minuziosamente il bendaggio di una mano, così come le ragioni di questa pratica e Tagli, dove si racconta la vita dei cutman e di tutta quella schiera di professionalità artigiane e carbonare che popolano gli angoli di ogni incontro. Perché un pugile, solitario per eccellenza, in realtà non combatte mai da solo.
Il circo del ring. Dispacci dal mondo della boxe insomma è tutto questo, un po’ almanacco un po’ bestiario medievale. Qualcuno lo chiamerebbe un libro-mondo. Un’indagine dal sapore antropologico – ricerca sul campo e graffito multicolore – un universo parallelo, in cui il pugilato è raccontato come: «Una sottocultura invisibile con un linguaggio e un’estetica propri. […] Esiste un’etichetta precisa, e ogni violazione viene punita senza esitazione. Il rispetto si guadagna e si concede». Insomma un tributo onesto a uno sport che troppo chiede e poco restituisce, ma che non fa niente per nasconderlo. Anzi ne fa vanto. Non millanta, né inganna. Richiede sforzi titanici e coraggio, ma non si presta a fraintendimenti. Rende tutto esplicito. Lineare. Ad azione corrisponde reazione. Botta e risposta. Colpo su colpo.
Filippo Petrocelli
