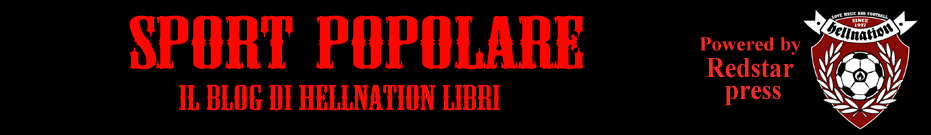Al netto delle dichiarazioni ufficiali o meno e di tutti gli orientamenti politici, le Olimpiadi fungono innegabilmente da catalizzatore di interesse – e perché no passione – non solo nei confronti di quegli sport più disparati che tendenzialmente vengono sottovalutati nel periodo che intercorre tra un’edizione e l’altra, ma anche verso uno slancio tendenzialmente patriottico che – con delle specifiche eccezioni frutto di conflitti e che rimanda ad altri tipi di patrie – ci porta a esultare per le vittorie anche in quelle discipline di cui ignoravamo l’esistenza fino a pochissimo tempo prima.
Certo, sicuramente poi siamo in tanti a non limitarci al tifo per la nazionale di riferimento, ma ad affiancare a essa altri interessi speciali. Non è certo un segreto che dal nostro blog seguiamo con passione gli sforzi e i successi e delle spedizioni di Cuba e del Venezuela e di altri rappresentanti del socialismo del ventunesimo secolo, così come poi a livello personale abbiamo simpatia per altre nazioni, come del resto succede a ogni latitudine.
Tuttavia, il discorso cambia quando ci sono selezioni che non possono avere una “fandom” di riferimento che appartenga a una qualche nazione. Questo è il caso delle selezione dei rifugiati, la cui denominazione ufficiale è EOR (che sta per Equipe Olympique des réfugiés), che ha debuttato con 10 atleti ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro – dopo che nel 2015 il CIO ha avviato un fondo di emergenza per i rifugiati in modo da integrarli e successivamente ha istituito delle borse di studio speciali per finanziarne le spese – ed è così giunta alla sua seconda partecipazione in cui sono presenti in 29 unità (11 donne e 18 uomini), 16 allenatori tra cui un italiano, Niccolò Campriani, pluri-medagliato nel tiro a segno tra Londra 2012 e Rio 2016, e 10 accompagnatori che si sono cimentati in 12 sport – judo, taekwondo, karate, boxe, wrestling, ciclismo, nuoto, badminton, atletica, sollevamento pesi, tiro a segno, canottaggio – e di fatto rappresentano 80 milioni di persone costrette a fuggire dalla propria terra per via della guerra o delle ristrettezze economiche e sociali.
Una partecipazione che si è rivelata difficoltosa già da prima dell’inizio ufficiale per via della scoperta della positività al Covid-19 di Tegla Lorupe, la ex mezzofondista keniota a capo delle delegazione, nonché una delle menti di questo progetto, riscontrata una settimana prima dell’inaugurazione, a Doha, ma dopo una situazione di stallo la delegazione ha potuto regolarmente partecipare alla cerimonia d’apertura, sfilando subito dietro la Grecia che tradizionalmente apre questa cerimonia in quanto patria delle Olimpiadi, con bandiera e inno olimpico.
I portabandiera designati sono stati la nuotatrice siriana Yusra Mardini che dopo aver rappresentato il paese nelle competizioni nazionali, nel 2015 fuggì da Damasco con la sorella arrivando in Germania dopo aver attraversato illegalmente ben sette paesi, ma soprattutto dopo aver salvato la vita a diciotto rifugiati a largo dell’isola di Lesbo trainando a nuoto una piccola barca; e l’eritreo Tachlowini Gabriyesos fuggito a soli dodici anni e che non vede la famiglia da otto.

Com’è facilmente immaginabile, non sono le uniche storie significative di un team che al proprio interno ha una ragazza come Masomah Ali Zada, ciclista afgana di etnia Hazara, fuggita due volte dai talebani: la prima verso l’Iran dove non ha ottenuto il riconoscimento di rifugiata politica in quanto senza documenti e la seconda quando invece il paese sembrava stabilizzato, eppure nessuno voleva vedere una ragazza andare in bicicletta e le persone sono arrivate a sputarle, insultarla, persino spararle e a rapire il suo coach, Sadiq Sadiqi; o Luna Salomon, eritrea allieva di Campriani che dopo aver attraversato il deserto a piedi ed essere sbarcata in Italia dalla Libia tramite i famosi barconi, è arrivata in Svizzera e molte altre ancora, molto diverse tra loro non solo nelle sfumature, ma anche nei contenuti. Ma in ogni caso, in un’edizione anomala come questa, senza pubblico e in preda alla paura, sono molto più che un semplice “omaggio al coraggio e alla perseveranza di tutti i rifugiati” come ha sostenuto l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ma sono allo stesso tempo un grido di speranza e la dimostrazione che si può sfidare e battere il proprio destino, sia sotto i bombardamenti che su un tatami o in piscina.
Giuseppe Ranieri