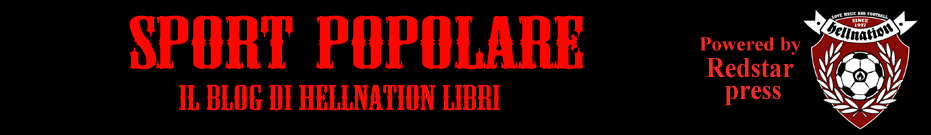Esiste un legame tra l’Irlanda del Nord e la Calabria che è sconosciuto anche ai suoi stessi abitanti. Lo si è rintracciato scavando tra le pagine più turbolente e dimenticate del secolo scorso, quando entrambi i territori venivano stritolati da tumulti sanguinari.
L’atroce massacro avvenuto tra le strade della città nordirlandese di Derry, passato alla storia come Bloody Sunday, ha rappresentato l’apice della faida cattolico-protestante che nel Regno Unito aveva innescato i famigerati Troubles. Quando il 30 gennaio 1972 il 1° Battaglione del Reggimento Paracadutisti britannico, capitanate dal Colonnello Derek Wilford, apriva il fuoco sui manifestanti, quella mattanza intrecciava inconsapevolmente sui suoi passi il destino della città di Catanzaro, che, per altri motivi, scolpiva nella sua memoria quel freddo e piovoso pomeriggio di gennaio.
Coincidenze e analogie
A oltre 50 anni dall’eccidio è necessario ricordare la vicenda per mettere in evidenza non solo le singolari coincidenze, ma anche per soffermarsi su analogie storiche e sociali tra i due luoghi. Mentre si consumava quella tragedia, infatti, nell’estrema periferia del meridione d’Italia, una squadra di provincia annientava calcisticamente la corazzata Juventus. Il 30 gennaio 1972 la capolista rendeva l’onore delle armi (tra le polemiche), nell’allora stadio Militare, al neopromosso e di certo meno attrezzato U.S. Catanzaro 1929, grazie al gol di Angelo Mammì, autore delle vittorie decisive dei giallorossi.
Per le Aquile, il successo contro la Juventus aveva un sapore differente: non soltanto per la vetrina calcistica, o perché era la prima vittoria di quel campionato, ma soprattutto perché simboleggiava la rivalsa di una terra prosciugata dall’emigrazione. Un fenomeno che da anni costringeva numerose famiglie in cerca di fortuna, a trasferirsi nell’opulento settentrione: quello stesso nord che, oltre ad accogliere migliaia di meridionali, li aveva fidelizzati come supporters della Vecchia signora.
Il trionfo sportivo permetteva di riunire quindi la Calabria intera sotto un unico vessillo, e ricuciva (in parte) anche le lacerazioni sociali createsi con i moti per il capoluogo: simili, per alcuni aspetti, alla disputa tra protestanti e cattolici.
Se il Bloody Sunday aveva rappresentato il culmine della faida anglo-irlandese, in Calabria dal luglio 1970, l’investitura di Catanzaro come capoluogo di regione aveva innescato l’insurrezione popolare della città di Reggio Calabria. Quella iniziale bega tra corregionali si era in realtà incardinata nel complesso panorama nazionale della “Strategia della tensione” servendo alle ’ndrine e all’estrema destra per i loro piani eversivi.
Così, per sette mesi, si era reso necessario l’intervento militare in riva allo stretto, mentre sulla sponda irlandese, le fila dell’IRA venivano ingrossate come risposta ai depistaggi continui sulle responsabilità delle truppe di sua Maestà, la quale, nel frattempo, aveva ritenuto necessario decorare il comandante Wilford con una medaglia al valore.
Esilii
Il filo invisibile tra l’Irlanda e Catanzaro riguarda anche la capacità di propagare quei riverberi nel mondo calcistico locale.
A causa delle condizioni sociali, per tredici anni il Derry City FC era stato costretto a disputare l’Irish League lontano dalle mura amiche.
Tutto era scaturito il 12 settembre 1971, durante la partita contro il Ballymena United, massima espressione della comunità protestante, quando i tafferugli innescatisi prima del match erano degenerati nel rogo del pullman della squadra ospite.
Questa motivazione, unita alle continue denunce sulle condizioni di sicurezza e di clima terroristico della città, avevano costretto all’esilio i padroni di casa.
La stessa tensione si respirava in Calabria nella stagione calcistica 1970/1971, quando le azioni di protesta contro Catanzaro Capoluogo avevano indotto la decisione del rinvio della gara contro la Reggina.
Per scongiurare problemi di ordine pubblico, la federazione (che aveva già costretto gli amaranto all’inversione di campo contro il Livorno e il Brescia) aveva dirottato l’incontro il 25 novembre a Roma.
Tuttavia, per rendere meno agevole il raggiungimento dei tifosi, la sede definitiva fu Firenze (sia all’andata che al ritorno), senza considerare, tuttavia, l’enorme bacino di emigrati nel nord Italia, che non si fecero intimorire dalla distanza e si riversarono in città già dalle prime ore del mattino.
Pierluigi Biondo