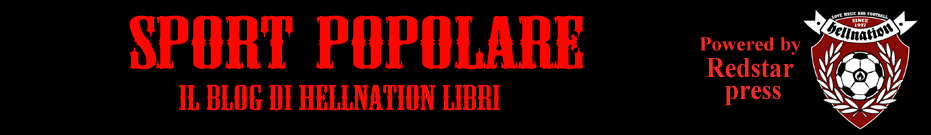Più di 209 anni fa un popolo eroico raggiunse l’indipendenza grazie al sacrificio e all’unità di tutti quelli che difesero la bellissima terra dei Guaranì. La libertà era il desiderio di coloro che cercavano a tutti i costi di difendere la propria storia, identità e discendenza affinché non venissero sterminate. Libertad è anche il nome di uno dei club più importanti di quel Paese, soprannominato “El Gumarelo”. Questo club è stato fondato il 30 luglio 1905 grazie agli sforzi di giovani e studenti che hanno definito il club come un’“Associazione atletica di esercizi fisici”, il cui obiettivo sarebbe stato promuovere il gioco del calcio, così come il vigoroso sviluppo dei giovani.
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria: Fuori dal campo

Il 5 maggio 1992, allo stadio Furiani di Bastia, durante la semifinale di Coppa di Francia, 18 persone morirono e più di 2000 restarono ferite.
La causa fu la decisione dei dirigenti del club Corso di sostituire in qualche giorno la tribuna esistente (750 posti) con una struttura metallica (9300 posti), allo scopo d’accogliere più persone possibili per la partita.
È stato provato che i lavori furono realizzati senza i permessi di demolizione necessari e la Lega Corsa fu investita da accuse di corruzione relative all’emissione di un falso documento che attestava l’avviso favorevole della commissione di sicurezza.
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria: Fuori dal campo

Nel corso della nostra attività ci è capitato più volte di seguire e documentare quanto i gruppi ultras siano stati importanti, se non a tratti decisivi, per la crescita e lo sviluppo delle proteste nei paesi del Maghreb che hanno assunto il nome univoco di “Primavere arabe”, nonostante spesso queste avessero caratteri mutevoli di nazione in nazione. Forse una delle poche costanti, principalmente per quel che riguarda Egitto e Tunisia, era proprio rappresentato da quell’elemento di rottura, prevalentemente giovanile e oltranzista, incarnato dai frequentatori delle curve che in tutto il contesto nordafricano rappresentano uno dei pochi spazi di dissenso e autorganizzazione consentiti. Anche il Marocco non è stato del tutto esente né dai sommovimenti sociopolitici né dalla presenza in essi dei supporters più esagitati.
- Dettagli
- Scritto da Giuseppe Ranieri
- Categoria: Fuori dal campo

Attingere al modello repressivo sportivo per porre fine alle violenze che hanno caratterizzato le manifestazioni dei Gilet Gialli. Davanti ai casseurs, il governo francese si ispira alle misure adottate in Francia contro l’hooliganismo circa una dozzina d’anni fa. In diretta al telegiornale delle ore 20 su TFI (canale privato di proprietà della famiglia Bouygues) Edouard Philippe, che vuole rafforzare l'arsenale repressivo contro i casseurs, ha elogiato le misure restrittive prese contro gli ultras nel corso degli anni 2000 utilizzate per “contrastare i disordini” durante le manifestazioni sportive negli “stadi di calcio”.
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria: Fuori dal campo