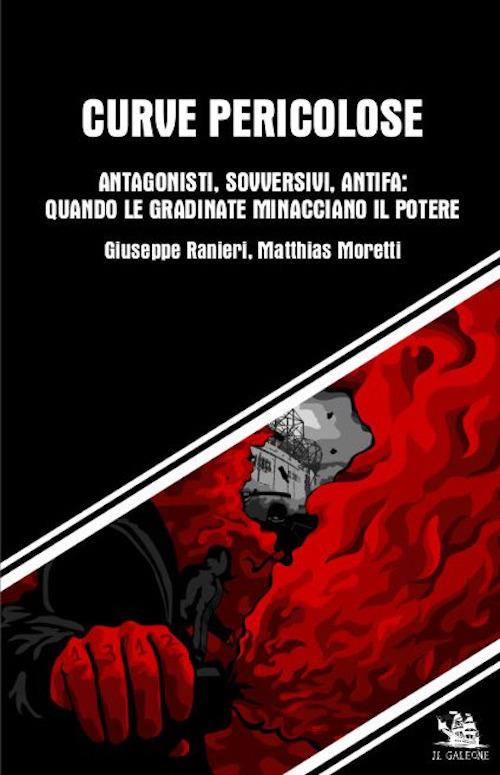
Conflitto è la parola che dopo oltre 50 anni contraddistingue e identifica molto bene il mondo Ultras.
Perché che vogliate o no, gli ultras, mutando sapendo negli anni mutare, sono gli unici che sono sopravvissuti a ogni cambio generazionale, storico e sociale (a differenza di partiti politici, movimenti, strutture politiche, ecc.); sopravvissuti a ogni batosta, sapendo controbattere colpo su colpo la repressione che ogni giorno subiscono da parte del potere costituito.
Che vogliate o no, chi esprime conflitto porta nelle sue istanze, istanze politiche.
Conflittualità che in molti casi è frutto di una storia sociale e culturale intrinseca nella comunità nella quale si rispecchia quotidianamente il gruppo ultras ed è questo che a mio modo di pensare emerge con molta forza dal libro Curve Pericolose scritto a quattro mani da Giuseppe Ranieri e Matthias Moretti, edito da Il Galeone Editore.
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria: Recensioni
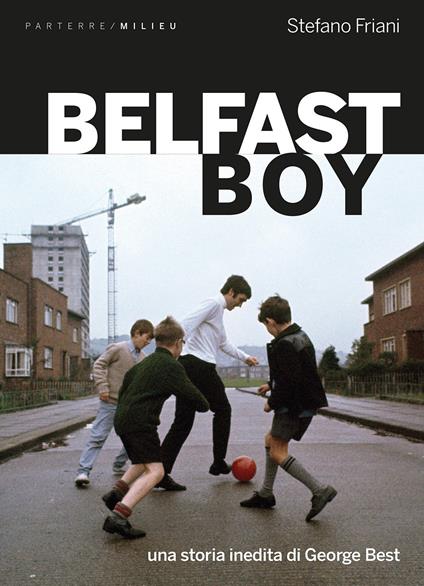
In Italia, ahinoi, porta lo stesso cognome di un bizzarro trasformista politico, simbolo della decadenza politica e della trasformazione nel nulla cosmico della sinistra tricolore: Migliore, sì ma Gennaro, il portavoce dell’inqualificabile mini-partito personale di Matteo Renzi. I più nostalgici come me magari ricordano un grande comunista come Palmiro Togliatti, soprannominato appunto “il Migliore”.
Ma la traduzione anglofona è Best, il nome è George insieme rappresentano quello che per un decennio è stato sicuramente il miglior giocatore europeo di calcio, appunto George Best.
Il libro di Stefano Friani, edito da Milieu Edizioni (320 pp., 17,90 euro) all’interno della collana Parterre, non si va aggiungere alla già abbondante bibliografia sul calciatore nordirlandese ma è un punto di vista che interseca giornalismo, saggistica e storytelling che aggiunge dei connotati che vanno oltre il bidimensionalismo (tutto buono o tutto cattivo) con cui quasi sempre è raccontata la storia di questo sportivo sui generis.
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria: Recensioni
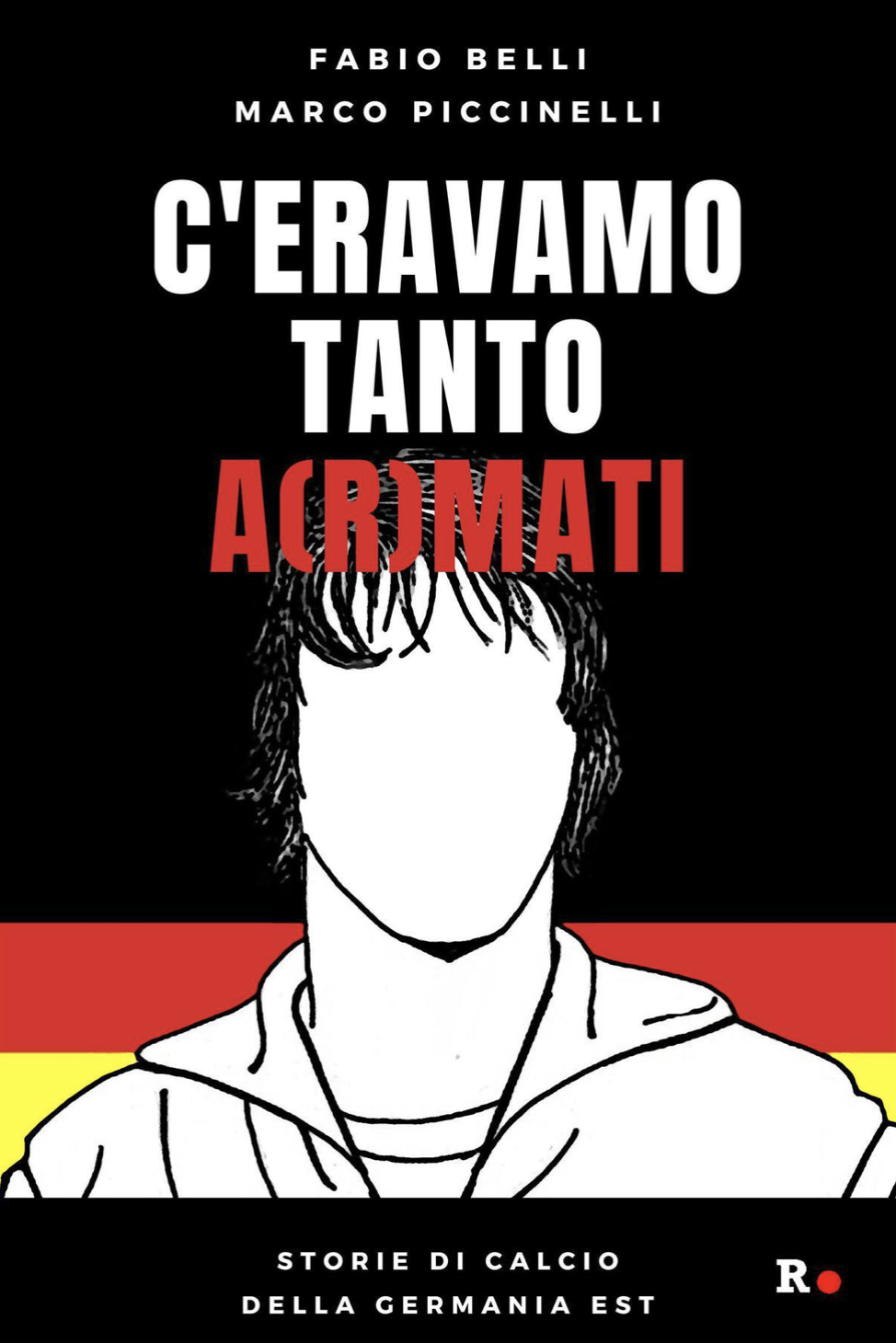
Che il duo Piccinelli/Belli fosse un’accoppiata vincente, lo provammo a suo tempo quando come sportpopolare.it organizzammo la presentazione della loro prima uscita Calcio e martello. Storie e uomini del calcio socialista. Ricordo con piacere il dibattito in quel del Sally Brown che ne scaturì, e quanta nostalgia rievocando i nomi dei profeti e delle icone del calcio del paese dei soviet. Nel loro ultimo lavoro però si evince anche una non velata “ostalgie” (come d’altronde a me, mentre vi scrivo) sul calcio della DDR. Un lavoro che loro stessi indicano “un lavoro di nicchia” ma scritto bene, ricco di approfondimenti e storie di quel calcio un po’ sconosciuto.
Edito dalla Rogas, un libricino di 133 pagine, tutte da leggere d’un fiato, dal titolo che un po’ rispecchia la simpatia e l’acume semantico dei due autori: C’eravamo tanto a(r)mati. Anche la copertina è da segnalare, con uno Spari Sparwasser senza volto ma perfettamente riconoscibile che a me personalmente è piaciuta molto. La immagino pensata e ripensata.
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria: Recensioni
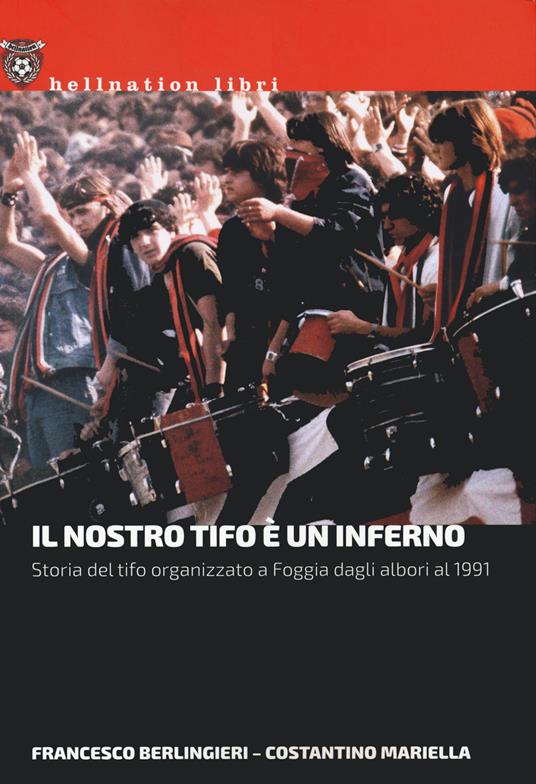
Parlare di tifo organizzato non è mai facile. Parlare di come è nato, cresciuto e diventato grande il tifo organizzato della tua città e dalla tua squadra del cuore ancora meno. Il rischio come in tutte le vicende ultras è quello di scadere nel culto del proprio io e non essere pienamente obiettivi in quello che si scrive e si vuole portare al lettore.
Francesco Berlingieri e Costantino Mariella con il loro ultimo lavoro editoriale Il nostro tifo è un inferno.
Storia del tifo organizzato a Foggia dagli albori al 1991, edito da Robertò Hellnation Red Star Press - Hellnation Libri, hanno la capacità di non scadere nel banale e in maniera oggettiva e documentata raccontano la nascita degli Ultras in quel di Foggia.
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria: Recensioni
